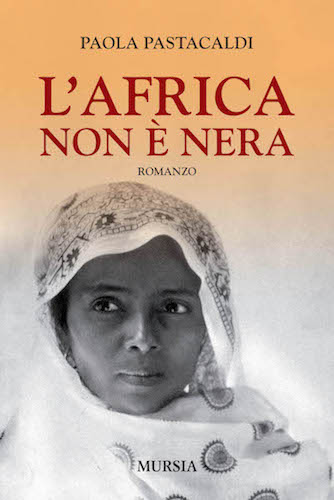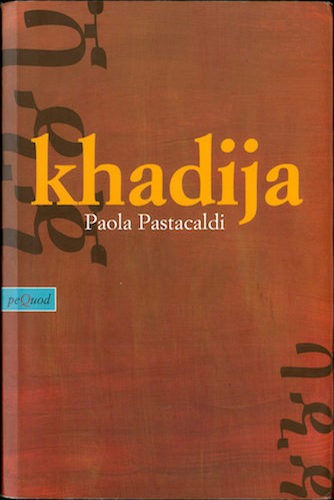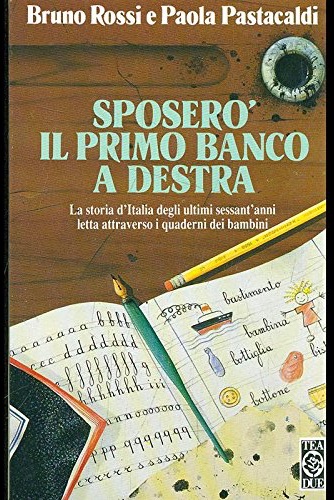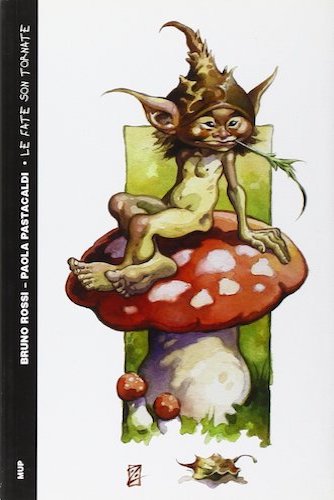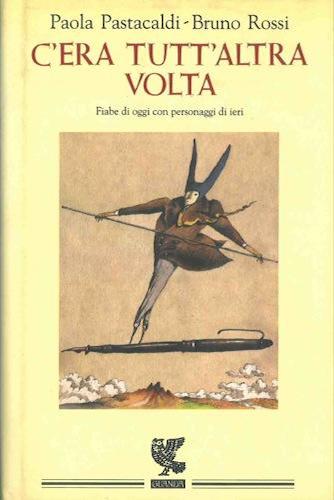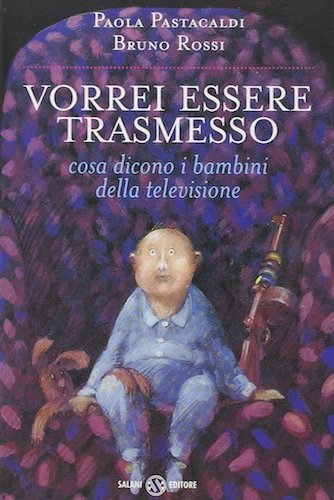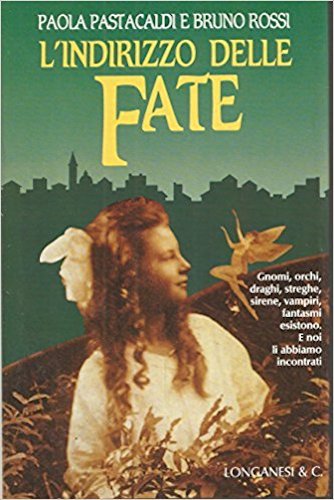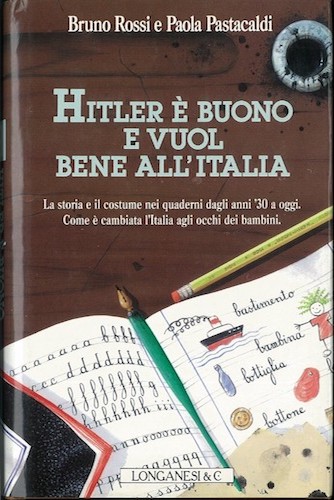di Luigi Finotto, Radio Sherwood, Padova
Sono nato in Eritrea, a Keren nel 1965. Mia madre è eritrea, mio padre italiano della provincia di Venezia.
Sono nato in Eritrea, a Keren nel 1965. Mia madre è eritrea, mio padre italiano della provincia di Venezia. Dall’età di 3 o 4 anni fino a quella di 9 o 10 ho vissuto ad Asmara con mia madre. A meta’ della quarta elementare, nel 1974, nel bel mezzo di una situazione di guerra tra il regime del negus che stava morendo e un altro che cercava di subentrargli e una guerriglia indipendentista che cercava di cogliere l’occasione per infliggere una spallata al regime, insieme ad altri italiani, fui forzosamente rimpatriato in Italia che mai avevo visto prima. Il viaggio da Asmara a Roma lo feci con mio padre, che aveva all’epoca più di 60 anni, mentre a mia madre, che era assai più giovane, essendo eritrea, non le fu permesso di venire con me. Mi raggiunse in Italia solo un paio di anni dopo, in seguiti ad un viaggio avventuroso, disgraziato, difficile e doloroso che durò quasi due anni, quello sì degno di un romanzo d'avventura . Quando mia madre giunse in Italia, mio padre era già morto da tempo, praticamente pochi mesi dopo il nostro arrivo in Italia. Io abitavo in provincia di Venezia con mia zia. Mia mamma comprese subito che non poteva essere un minuscolo paesino veneto di metà degli anni Settanta il luogo dove una donna africana senza particolari competenze potesse rifarsi una vita. Io vivevo con mia zia, preside di una scuola, la quale poteva provvedere alle mie esigenze, per cui mia madre si stabilì a Roma, dove già allora c’era una comunità eritrea compatta e solidale e nel cui ambito si poteva sperare di ricostruirsi una vita e trovarsi un lavoro. Continuammo naturalmente a vederci con frequenza ma, ormai era tutto diverso tra noi. Come molte eritree fece la colf e lo fece da quel momento per i successivi 30 anni. La mia vita, invece, mori quando io lasciai l’Eritrea e in Italia ne iniziai una seconda, di gran lunga uno scarto della prima. Dopo due anni in Italia avevo dimenticato totalmente la lingua tigrina che parlavo perfettamente, avevo eliminato dal mio cervello il ricordo di nomi e volti che avevano abitato la mia quotidianità’ per nove anni, avevo compromesso in parte il rapporto affettivo con mia mamma che prima era di una intensità’ quasi morbosa. Colori, sapori, tempi, rumori: tutto diverso, tutto estraneo. Avevo cessato di essere ciò che ero, senza però diventare un altro. Ero una sorta di cancellino perenne di me stesso in servizio permanente, ero come la sabbia di una clessidra che aveva un buco in fondo. Cosi è stato per anni, vita senza un passato e con un presente un po’ rabberciato. Poi durante gli anni dell'università qualcosa cambiò: una strana ripresa di uno strano orgoglio africano, scaturito da qualche lettura, da impegno politico, da qualche conoscenza diretta e iniziò la voglia di ricomporre le tessere smarrite e rovinate di quel puzzle che furono i miei primi 10 anni, cioè quel tempo che se anche dovessi morire a 150 anni resteranno gli anni della mia vita. Ascoltavo mia madre e lentamente, attraverso i suoi racconti, mi recuperavo, mi riscoprivo, mi reinventavo. Scoprii ciò che già sapevo ma avevo rimosso. Mio padre mi ebbe da anziano, mia madre mi ebbe da giovanissima, una cosa assai frequente nelle “coppie “miste italo eritree di allora, avevo almeno un altro fratello che mio papà ebbe da un'altra donna e che mai riconobbe: mio papà andò in Eritrea giovanissimo, poco piu' che ragazzino e ci rimase tutta la vita Era un agronomo e lavorava nelle concessioni italiane. Tesseney, Elabereth e Ghinda furono le tre zone che contribuì a bonificare e a rendere agricole e fertili. Tipo strano: veneto, taciturno, grande lavoratore, super fumatore, amante degli scacchi e dei libri gialli. So per certo che non mi riconobbe subito, che mia mamma lottò molto perché lui lo facesse. Mia mamma è nata a Keren, è bilena, anima ribelle seppur cattolicissima Scappò di casa da giovanissima e andò a Elabereth e li iniziò a lavorare in una concessione italiana (credo i Casciani), qui incrociò' mio padre e nacqui io. Non ho ricordi di scene di affetto tra mia madre e mio padre e penso che abbiano vissuto assieme pochissimo, forse mai, di certo mai da dopo la mia nascita. Rammento solo (in questa strana forma di memoria che ho) che una volta al mese veniva da Ghinda ad Asmara per trovarmi. Mi teneva sulle sue gambe, per me era un gigante che mi metteva soggezione, un po’ lo temevo, non mi sentivo alla sua altezza e in fondo non vedevo l'ora che ritornasse a Ghinda. L'estate la passavo con lui a Ghinda che è vicina a Massawa, stavo nella sua stanza d'albergo, nella mitica pensione “Buonrespiro”, dove lui viveva. Ha vissuto una vita in Africa senza mai avere casa, sempre in albergo. Giravo per la concessione, giocavo coi bambini italiani e meticci, raramente con i neri. Erano più sporchi di noi, più' aggressivi di noi e ci sembrava che non ci volessero un gran bene. Cosi li vedevo. Nei miei frammenti di ricordi i rapporti tra bianchi e neri negli anni 70 non erano poi cosi idilliaci. C'era una reciproca indifferenza, non una grande stima reciproca e ognuno cercava di “succhiare” dall'altro il meglio per sè. Frequentavo la scuola “La Salle”, novanta per cento bianchi e meticci, pochi neri e quei pochi neri erano più bianchi dei bianchi. Una scuola che col senno del poi, si può dire fosse una scuola fascista, come per altro lo erano quasi tutti gli italiani in Eritrea compreso mio padre. Scuola molto machista, gerarchica, dura, con tanto di saggio fisico a fine anno e relativo maschio e virile tuffo nel cerchio di fuoco. C'era la squadra di calcio. Erano tutti bianchi tranne uno che era meticcio. Gli italiani si sentivano a casa loro e non percepivano gli eritrei come loro pari. Li consideravano bene solo se erano utili servili e disponibili, li accettavano nella medesima scala solo se stavano un paio di gradini sotto, solo se accettavano il destino di essere italiani in scala minore. Non fummo poi cosi tanto “italiani brava gente” . Quando tutto finì, furono giorni orribili. Rumori di bombe, di mitraglie, chiusi a casa dalle sei di sera fino al mattino dopo, con la paura addosso di morire, attaccato a mia mamma come se fossi nuovamente nel suo utero Poi fini tutto. Era il 1974 forse il ‘75 e venni qui una giornata di febbraio con un freddo tremendo. Mi guardai intorno, era tutto diverso da Asmara. Pensai solo che la guerra fa schifo e che io ero una vittima della guerra. Morivo lì.