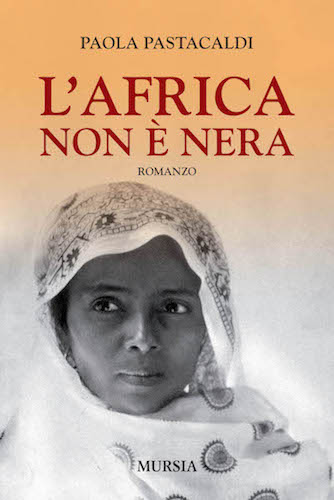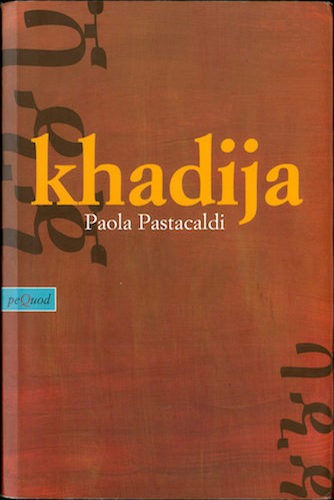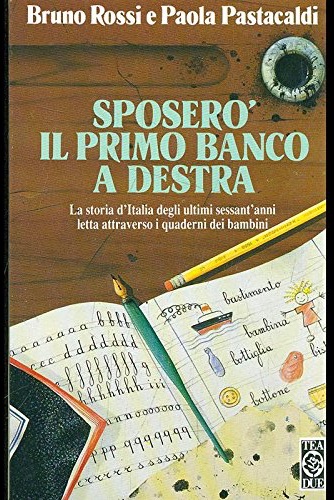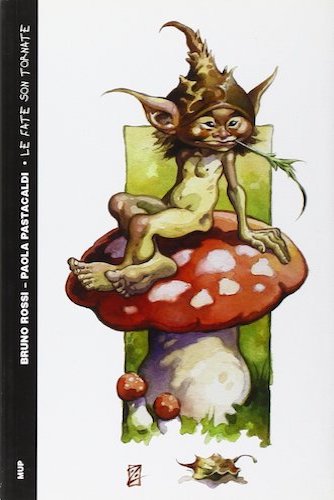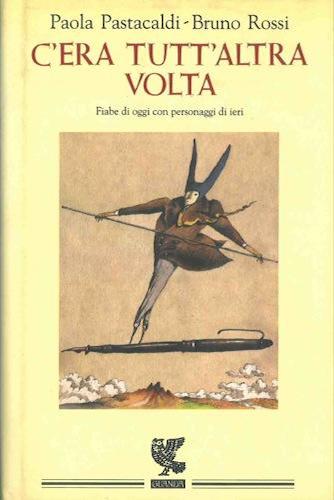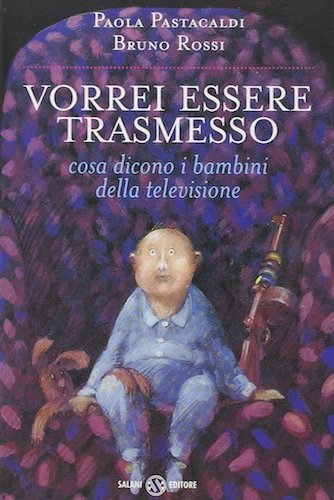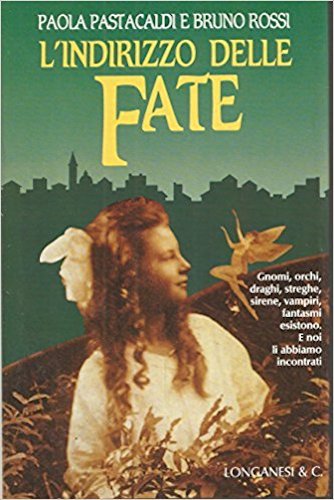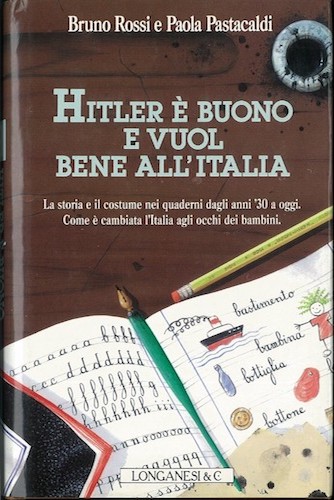“Ho visto Fuocoammare” di Paola Pastacaldi
Ho visto Fuocoammare, il film di Gianfranco Rosi premiato con l’Orso d’Oro al Festival Internazionale del cinema di Berlino. Temevo di dover vedere ancora più orrore di quello che vediamo tutti i giorni nei tg, la morte narrata con le banali parole dei giornalisti, e l’inferno dei migranti fattosi spettacolo, perché privo di emozioni nella sua ripetizione e nell’anonimità dei numeri. Temevo di conoscere le storie di quelle persone che fuggono da guerre, fame, Isis e muoiono annegate, soffocate, picchiate, stuprate, violentate prima di toccare la terra che per loro simboleggia la Sopravvivenza e l’ultimo straccio di una volontà di vivere, l’ultima, l’ultima davvero, Speranza, prima di lasciarsi trasportare dalla disperazione della morte psichica e fisica. Temevo in sostanza, penso come tutti, di dover fare i conti con ciò che quelle morti provocano in noi cittadini di un Paese senza guerra, senza carestie, senza Isis o dittature di qualunque tipo. Paura dell’Inferno, una paura ancestrale. Paura del dolore e del male.
Ho visto, invece, un film potente, perché intriso di poesia e di immagini estremamente curate e semplici, un film che non parla solo dei migranti, ma che parla di noi, delle nostre vite comuni, in questo caso quelle dei siciliani di Lampedusa. Un film corale, che ha tra i protagonisti anche un bambino che si costruisce ancora la fionda per cacciare gli uccellini, che già a dieci anni ha nel cuore il mito di sparare e lo fa armato di un fucile immaginario. E’ come se quel gioco denunciasse un degrado educativo, non tanto del bambino quanto di noi, della nostra società. Non abbiamo saputo andare oltre il nostro benessere che ci rende polo di attrazione per i migranti, non abbiamo saputo fare dell’ambiente un valore, per farlo capire ai giovani. Ecco il bambino, che di notte cerca di uccidere gli uccelli che cantano nei nidi, nel disarmante bellezza paesaggio siciliano che ha tratti di antichità rari. E come se il film dicesse ai migranti: “Guardate, questo è il Paese dove state per arrivare, questo è il Paese che sognate di raggiungere”. C’è una cesura secca tra la morte dei migranti sulle coste di Lampedusa e la vita arcaica degli isolani. Due mondi che non si incontrano per mille motivi da indagare.
Fa paura all’inizio del film quel bambino che ha già nel cuore il seme di una violenza che potrebbe travolgerlo, ma che, donandoci una speranza, verso la fine imparerà ad accarezzare un uccellino nascosto in un cespuglio, imparerà a lasciarlo vivere, anziché ucciderlo con un sasso e una fionda.
Il film racconta anche la vita quotidiana, la banalità quotidiana, di piccole cose sicure, il far da mangiare della moglie del pescatore, il rifare il letto, rammendare, lo speaker che lavora in una radio, che manda in onda le musiche da dedicare, il pescatore che insegna al figlio come era duro l’andare per mare, come si faceva una volta. Ma ormai tutto è cambiato, i migranti arrivano sempre e continueranno ad arrivare e a morire in mare ancora per molti anni. Tra i due mondi nel film non c’è quasi storia. I primi chiusi nei Centri di accoglienza, gli altri chiusi nella loro vita antica e tutto sommato povera.
Il mare è nel film un altro grande e silenzioso protagonista, è lo scenario indissolubile di tutto ciò che avviene, tutto comincia con il mare e con l’immagine di alcuni giganteschi radar proiettati verso un orizzonte altrettanto terribile e oscuro che servono a raccogliere le voci dei migranti nei barconi, per cercare di capire dove si trovano, per salvarli dalla morte.
Il mare è il grande simbolico protagonista, il mare dei siciliani, la loro dannazione, un mare sempre descritto come temporalesco, sovrastato da un cielo arrabbiato e grigio. Non c’è molto sole in Fuocoammare. Il mare che vediamo sembra sancire la sua onnipotenza su tutti, sui migranti e sui siciliani. Le storie dei migranti vivono e muoiono dentro quel mare. Il mare è la forza del destino, la violenza della vita che decide chi deve morire e chi potrà sopravvivere. C’è una fredda casualità nelle loro morti.
Mi spiego meglio. Quante volte ho ringraziato Iddio di non avermi fatto nascere in un paese come la Siria, l’Eritrea o la Libia o dove c’è l’Isis. Anche io avrei tentato di fuggire, anche io avrei fatto qualunque cosa per sottrarmi a simili destini. Ne sono certa. Altrimenti sarei morta di inedia. Chi fugge rifiuta l’inedia.
Quando la scena del documentario si sposta sui migranti, nel Centro di accoglienza cintato da alte sbarre, come una prigione, alcuni di loro di varie nazionalità intonano un canto drammatico; recitano il loro viaggio fino a Lampedusa ed è una canto sacro che percorre l’Inferno che questi migranti hanno affrontato passando per Libia, Il Sudan, l’Egitto, le violenze, gli stupri, le prigioni che durano a volte anche anni. Un canto angoscioso che, alla fine, ringrazia per aver avuto salva la vita.
“Sono vivo”, conclude la voce di un africano e sembra la catarsi di una nuova tragedia greca. C’è poi la Speranza, ci sono i migranti ripresi mentre giocano a calcio, un paese contro l’altro, e gli spettatori gridano i nomi dell’Eritrea e della Siria. Non a caso, visto che sono i due Paesi più rappresentati tra i profughi che arrivano nel Mediterraneo. Poi ci sono i corpi dei morti prelevati dal barcone, già nei sacchetti neri. La macchina da presa si sposta nella stiva, dove giacciono quaranta cadaveri, abbracciati e uniti come un corpo solo.
Il film non indulge in immagini troppo dure o forti o commoventi. In questo senso è un film straordinariamente equilibrato. Con le parole dell’umile medico Pietro Bartolo che da anni fa la prima visita a quelli che sbarcano a Lampedusa e che racconta l’angoscia che nessuno gli può alleviare, e a cui non vuole sottrarsi, cioè al dovere di visitare cadaveri, gente picchiata, bruciata dalla benzina, donne incinte, neonati morti, ancora legati col cordone ombelicale.
“Siamo tutti africani o siriani”, verrebbe da dire. Ecco il film è duro perché trasforma lo spettatore in un ipotetico migrante da sempre al sicuro che non può, però, sottrarsi alla responsabilità di quelle morti e alla domanda che l’arrivo dei migranti gli pone sul loro futuro. Ci si sente male ad essere spettatori seduti al caldo, a guardare, nelle comode poltroncine di velluto del cinema ciò che accade a Lampedusa, ad assistere alla fine di tanti esseri umani con storie a noi sconosciute così disperati da rischiare la vita.
Questo film ha l’intuizione di aver capito che non servono immagini più forti, - quelle le vediamo praticamente tutti i giorni in televisione o anche sui giornali -; è sufficiente creare lo stato d’animo per quella domanda che lievita inesorabile fin dall’inizio della narrazione del film e che chiede, pressante, allo spettatore: “E tu?”.