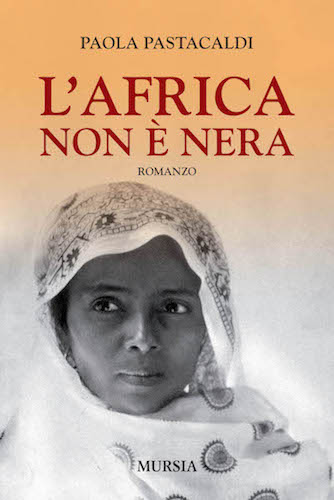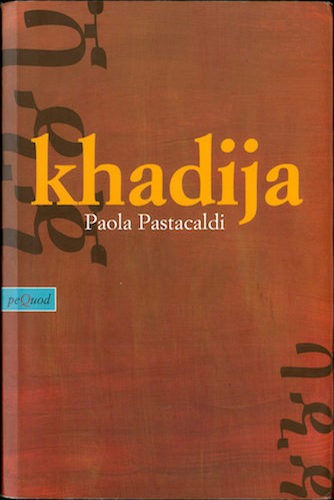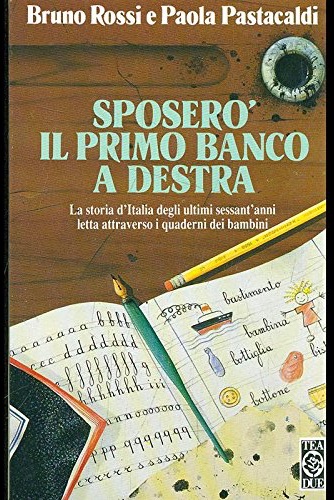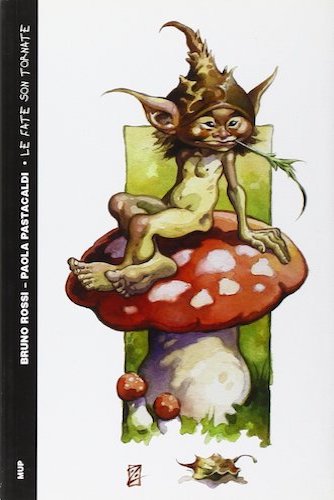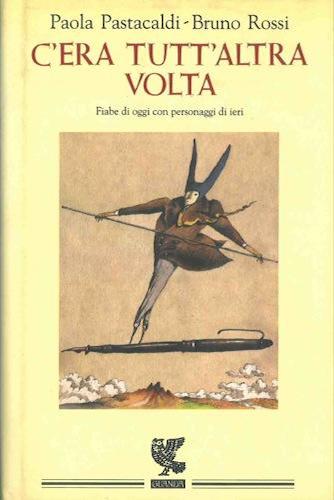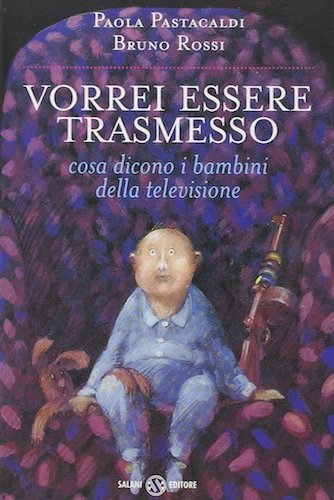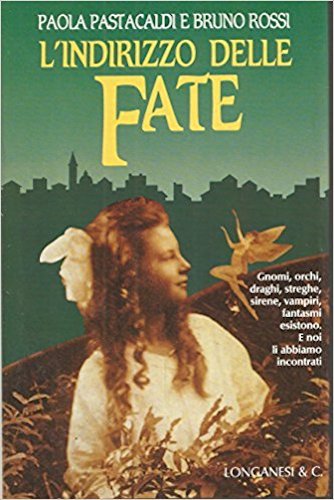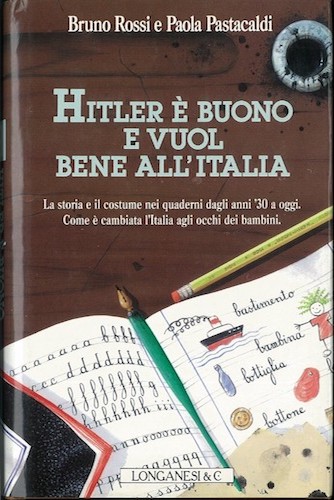“The House he built” - Nuovo articolo sul documentario e un nuovo Trailer da vedere. Link a fine articolo
Leggo la definizione di anziano su Wikipedia e penso all’ageismo. Come mi ha ben spiegato una geriatra amica, familiari e, a volte, anche medici si accaniscono in una pervicace e dannosa discriminazione, una specie di razzismo verso gli anziani, basandosi su presupposti legati all’età avanzata e al decadimento cerebrale, dato per scontato sempre (anche quando forse non c’è).
Mi viene da dire, che è un po’ come si fa nel separare bianchi e neri. Se un anziano, sulla cui definizione potremmo discutere a lungo, ma lasciamo perdere, ha un problema, un bisogno, gli si dice “Che pretendi alla tua età? E automaticamente li si esclude dalla possibilità di curarsi o di stare meglio o anche di esprimere delle opinioni, dei pensieri; gli si impedisce di continuare a cercare lo stare meglio, in parole più povere gli si impedisce di continuare a vivere. Un apartheid dell’età, ammettiamolo. Fatto per ignoranza, alla fine. Che le persone anziane abbiano solo e sempre limitate capacità rigenerative è una idea vecchia e superata dalle ultimissime ricerche. L’anziano morirà, come tutti noi, ma finché è vivo le sue capacità mentali possono non sopirsi, e persino consentirgli una ristrutturazione delle mappe cerebrali e un miglioramento delle funzionalità mentali attraverso esperienze di apprendimento. E’ la scienza recente a sostenerlo con forza: il cervello può essere plastico anche a novant’anni, ovvero l’apprendimento non ha età.
E’ una idea che può cambiare molti dei nostri atteggiamenti sugli anziani. Perché, per esempio, non occuparci, di loro in modo più serio, valorizzando il loro vissuto?
Lo ha fatto con notevole ardimento e creatività la regista Caterina Borelli con il documentario The House he Built, imperniato sulla storia personale e la memoria del luogo in cui abita il padre Sergio Borelli, 93 anni, giornalista eccellente degli anni Cinquanta, i primi anni d’oro del piccolo schermo. Un atto d’amore, ma anche un pretesto per parlare di qualcosa che riguarda quasi tutti noi, la vecchiaia.
Per chi si occupa di comunicazione, sia giornalistica che di intrattenimento, cartacea o cinematografica o televisiva, la domanda di base che si fa in questi casi è: perché fare un documentario su un uomo di 93 anni, dunque, alla fine del percorso vitale? La risposta ovvia è perché è stato un giornalista famoso e forse anche perché la figlia è una giornalista, lo zio è stato il direttore del Corriere negli anni Trenta, quando ci scriveva Curzio Malaparte.
E’ una risposta banale, in parte incompleta. The House he built è molto più di una narrazione personale su un giornalista, ancorché degno di essere raccontato. Come scrive la regista Caterina Borelli alla pagina Facebook intitolata The House he built – documentary in progress, il documentario di cui parliamo è il ritratto di una forte relazione tra Sergio e lo spazio in cui vive e la moltitudine di oggetti che ha raccolto negli anni di viaggi speciali e di incontri, altrettanto unici, che messi insieme formano la sua e la nostra memoria storica. Ma è anche una conversazione tra le differenti generazioni che hanno vissuto con lui nella stessa casa, tre per la precisione, tutti professionisti nel campo dell’informazione.
Questo documentario è una magnifica riflessione, commovente e a volte surreale per lo schema narrativo che ha scelto, sulla memoria e l’invecchiamento, che tanto spaventa questa società iperattiva e ipertecnologica, convinta di dominare tutto col suo assurdo efficientismo, che poi si scontra con le incongruenze dell’invecchiare, le quali – per fortuna – talvolta sanno mandare in tilt tutto il super apparato organizzativo e la finta sicurezza di chi tratta la morte come un incidente di percorso.
Caterina Borelli che firma il documentario, assieme ad un team composto da due nipoti, Nora Guicheney (direttore della fotografia) Malva Guicheney (sceneggiatrice) e Aline Hervé, come editor, sta ultimando il montaggio, dopo quattro anni di riprese. Caterina Borelli è regista e documentarista, lavora a Otto e Mezzo, e ha alle spalle una lunga esperienza in America.
Tornando al documentario, la chiave di lettura è legata alla casa un po’ speciale di Sergio Borelli. Perché, parafrasando il filosofo della scienza e poeta Gaston Bachelard, la casa altro non è che il nostro angolo del mondo. Sergio Borelli, nelle vesti di padre giornalista, diventa così una sorta di deus ex machina che agisce e fa agire la sua storia personale dentro le pareti della casa che diventa essa stessa una memoria viva. La casa riflette la storia di Sergio Borelli, la casa è Sergio Borelli, nello svolgersi delle diverse generazioni che lo hanno accompagnato, mentre invecchiava. E’, ovviamente, anche la storia di un giornalista che ha fatto il giornalismo legato alle immagini, quello della televisione, ma è anche la storia della sua personalità e del suo modo di vivere da anziano dalla mente così viva e agile da meritare la nostra attenzione e il nostro ascolto.
La casa in cui è ambientato il documentario è una versione forse più complicata della casa di Buster Keaton in Sign High: basta dare uno sguardo alla pagina Facebook dedicata a The House he built. La casa di Keaton è come un ciclo continuo, dentro fuori, su e giù senza fine, fino alla fine, della vita. La casa di Sergio Borelli ha tre piani che si sono moltiplicati in altri mezzi piani, grazie alle sue bizzarrie di non architetto. Un dedalo di cinque tortuosi piani, nel cuore di Trastevere, pieni di originali mobili in legno costruiti da lui stesso e riempiti all’inverosimile dei cimeli di una vita: migliaia di libri, immagini e oggetti collezionati in oltre sessant’anni di viaggi in giro per il mondo, all’inizio come inviato, poi come pioniere dei format televisivi e fondatore di Input, la Conferenza Internazionale sulla Televisione Pubblica.
Il documentario ripercorre la vita di Sergio Borelli attraverso i racconti che lui stesso fa alla telecamera della figlia e alle nipoti che compaiono nel film, accompagnandole di stanza in stanza come in un viaggio sia interiore che nel mondo.
“Come prima Sergio Borelli viaggiava di paese in paese, - si legge in una nota su Facebook - adesso sono gli oggetti che lo trasportano nel tempo e nello spazio. Lo stretto rapporto che c’è tra Sergio Borelli, lo spazio in cui vive e gli oggetti che ha conservato, è un richiamo a riflettere sulle nostre esistenze, su ciò che conta e ciò che invece diventa col tempo un ingombro. Inoltre, nelle conversazioni tra generazioni diverse della famiglia emerge un’interessante riflessione a più livelli sull’invecchiamento, sul valore della testimonianza e della memoria. In sintesi, sul modo di vedere, conoscere e capire il mondo, su come è cambiato – o non lo è?”. Sante parole.
Guardo varie volte il sito del documentario. Mi accoglie l’immagine di Sergio Borelli, capelli e barba bianca che lo fanno assomigliare ad uno gnomo autentico, sempre vestito bizzarro, si capisce che non è una mente comune, avvolto nella sua felpa, mentre ancora batte sulla macchina da scrivere, una storica Lettera 22 color verdino, con le note trionfanti di una musica nota di cui non ricordo il nome. Le immagini scorrono nella quotidianità, tra gli oggetti. Ma dato che la memoria non è mai lineare e così anche il documentario non è lineare, ma quasi impressionista nell’alternare immagini e emozioni di storie presenti e passate.
“Un giorno – racconta Caterina Borelli - ho trovato il copione di un servizio di mio padre del 1966 sul primo Festival Mondiale di Arti Negre a Dakar in Senegal. Il suo badante di oggi è un senegalese. Lo hanno visto insieme e così prendendo spunto da questo servizio è nata una triangolazione di pareri e opinioni su quel Festival, sul viaggio, tutto a distanza di oltre 50 anni; si è creato un flusso della memoria”.
“Sono proprio belli”, dice Sergio Borelli guardando delle pergamene etiopi. La camera da presa fa vedere statuette, dipinti, angeli. “Qui c’è un po’ di paccottiglia che messa insieme forma la memoria di qualcuno, cioè di me – continua con una punta di autoironia Sergio Borelli, rovistando tra le sue cose –. “Una bambola di cera di Timbuktu, le tette, una bocca, - continua estraendo da un cassetto dei voti d’argento -; sono una specie di storia intima del nostro tempo. Qui ci sono libri sulla religione e di là sulla televisione”. Poi le foto: “Io a Mosca, io a San Pietroburgo, io a Machu Pichu, io con delle donne indiane in Cina, in Messico a cavallo e una ferrovia andina. Tutto raccolto per non si sa più quale ragione, che forma la memoria”. E’ una ammissione direi notevole, forse grandiosa, che getta l’ascoltatore oltre la perdita della memoria minuta di cui soffrono quasi tutti gli anziani e vissuta sempre come una tragedia. Forse dobbiamo convivere con questa tragedia. Forse potrebbe non essere una tragedia. La vecchiaia, appunto.
Caterina Borelli, perché questo documentario su tuo padre?
“Il mio obiettivo era quello di fare il ritratto di una persona, delle sue esperienze di vita professionale, ma volevo farlo attraverso lo spazio che lui stesso si è costruito intorno. Il titolo lo dice chiaramente, The House he built. La casa è una forza motrice di tutto, rispecchia varie storie, vari momenti della vita. Nel documentario si vede lui che gira per la casa e intanto parla della sua vita, una casa apparentemente inadatta ad un anziano, ma che in famiglia abbiamo deciso di lasciare così com’è. Dopo la morte di mia madre, ho visto che aveva voglia di parlare e gli ho chiesto se voleva che lo filmassi, anzi me lo ha chiesto lui stesso, voleva farsi filmare. Sergio ha sempre lavorato in televisione, era in Rai a fine anni Sessanta e Settanta, mia madre andava al bar per vedere i servizi che lui faceva. Faccio vedere la realtà di oggi, ma anche degli accadimenti avvenuti nella stessa stanza in un periodo precedente. La casa evoca varie storie, altre persone che l’hanno abitata sempre della stessa famiglia”.
Il tuo è un film sulla memoria.
“Sì il mio è un film sulla memoria, sulla vecchiaia e su quello che noi chiamiamo la Casa. La Casa contiene le memorie, è un contenitore. Una raccolta di oggetti che ti ricordano la vita, ma poi con l’andare degli anni non ti ricordi più perché hai preso tutti questi oggetti. E’ il tema anche dell’accumulo della nostra società. Accumuli, accumuli e poi quando ti fermi non sai più perché, non ti ricordi perché hai preso quegli oggetti. Mio padre è consapevole di ciò, sa che quegli oggetti gli piacevano, che sono parte della sua identità e non se ne vuole disfare, nemmeno se non si ricorda più perché li ha. Lui vive in questa casa di tre piani, dove gira ancora a piedi; ci siamo chieste noi sorelle, varie volte, se era meglio prendergli un appartamento più comodo e agevole. Ma ci siamo sempre risposte no, che doveva rimanere lì dove è vissuto. Nel documentario voglio fare vedere una persona di 93 anni che è ancora presente, che ha ancora molte cose da dire, che è attiva mentalmente nella società. E’ una persona che esiste, che ha una capacità e una presenza forti. Sono stanca di vedere solo storie di anziani tristi, vorrei celebrare l’anziano che ha ancora voglia di parlare e di raccontare e lo farò attraverso un percorso fisico dentro la casa. Nella casa dove si intrecciano storie di altri, le figlie, mie sorelle, le nipoti, le badanti e i figli delle badanti, gli amici, un ciclo continuo in evoluzione”.
Quali sono stati i tuoi riferimenti culturali o cinematografici.
“Direi la Geologia di un padre di Valerio Magrelli, ma anche a La poetica dello spazio di Bachelard, Ryszard Kapuscinski: Life di Domoslawski e il Camilleri ne I racconti di Nenè, raccolti da Francesco Anzalone e Giorgio Santelli. La casa di Jaques Tati in in Mon Oncle e Toute la mémoire du monde di Alain Resnais”.
La storia professionale di tuo padre rimane, comunque, una storia da raccontare, no?
“Quando mio padre si trasferì da Milano a Roma prese una casa antica nel quartiere popolare di Trastevere e la svuotò tutta per rifarla a modo suo. La sua vera passione era la falegnameria, per questo si fece lui tutte le librerie che si vedono nel documentario, per raccogliere tutto l’enorme materiale che aveva accumulato in anni di viaggi e di lavoro.
Era appena morto Mattei e la nuova direzione del Giorno non gli piaceva, si mise a lavorare da indipendente e poi la Rai lo assunse a Roma. Qui nella casa che si vede nel documentario abbiamo vissuto tutti, io con quattro sorelle, e anche alcuni nipoti”.
Come è diventato giornalista Sergio Borelli?
“Durante la guerra era scappato e si era rifugiato in Svizzera, dove ebbe la possibilità di seguire delle lezioni di linguistica. Ma non si è mai laureato. Poi alla fine della guerra, un giorno, incontrò un amico per caso - così lui stesso sottolinea il suo ingresso nella professione – il quale lo invitò a collaborare ad una giornalino. Negli anni Cinquanta vinse un Bando dell’Unesco che aveva come tema “rieducare i giornalisti fascisti”. Prese il bando con spirito e scrisse un articolo di tono opposto, inneggiando alla Russia socialista e a Stalin. A sua sorpresa venne selezionato e chiamato a Londra per fare il tirocinio in una serie di giornali locali: si trovò a fare il cronista in mezzo a pescatori e minatori e imparò a raccontare. Rientrato in Italia, un paio di anni dopo, il Giorno lo assunse e nel 1956 lo inviò a Mosca come corrispondente. In questa fase della sua carriera il centro dei suoi interessi furono due grandi progetti rivoluzionari: la Russia socialista e la Cina comunista. Mosca fu una grande opportunità, ma si rivelò anche una grande delusione. Il papà aveva uno zio Aldo Borelli, direttore del Corriere della Sera negli anni Trenta, quando collaborava anche Curzio Malaparte (fu questo direttore a commissionare allo scrittore una serie di articoli sull’Impero bianco di Mussolini, n.d.r.). Mia madre lo esortava spesso a diventare un giornalista di successo come lo zio Aldo del Corriere della Sera, ma lui rispondeva che “per carità non voleva assolutamente imitarlo, perché era un giornalista di potere”.
Cosa ti raccontava degli inviati speciali di allora?
“All’epoca formare un inviato speciale era molto costoso – così mi spiegava lui stesso –; per i giornali era una specie di investimento. L’Avanti, il quotidiano socialista, lo mandò in Russia: fu il primo corrispondente italiano a Mosca durante la guerra fredda, e divenne uno specialista della Russia. I giornali di allora tendevano ad utilizzare una persona sull’argomento in cui si era più formata. A lui interessarono molto le grandi utopie, seguì sia la Cina che la Russia, e anche le prime indipendenze africane, come la Guerra di Algeria, per la quale è stato minacciato e ha dovuto scappare”.
La Russia socialista, come la visse?
”Una grande delusione, tanto che credette di aver mal di cuore, si sentiva oppresso, mi disse, tanto che desiderò morire, ma fuori da Mosca. Tutto il controllo che c’era, lo opprimeva e ritornò in Italia”.
La prima televisione come la racconta?
“Erano gli anni Settanta, il periodo d’oro della televisione. In tutta Europa e negli Stati Uniti si sperimentava, era il periodo della Magnet Tv Net di New York, di Nam June Paik, di Bill Viola, di Robert Cahen e in Italia di Ugo Gregoretti. Sergio sperimenta nuovi formati, passando dalla notizia scritta a come viene presentata, cioé la notizia attraverso le immagini. Ma nella Rai lottizzata del tempo questo suo interesse non lo portò lontano. Fu messo da parte dalla Rai, si rivolse all’estero dove insieme a colleghi di altri paesi europei fondò Circom, European Association of Regional Television e, in seguito, Input-tv, Television in the public Interest. Dal 1990, quando andò in pensione, si è dedicato a Input dove è stato International Program Coordinator, cioè incaricato di cercare nei paesi in via di sviluppo programmi da presentare alla Conferenza. E’ l’ultimo dei padri fondatori di Input ancora vivo”.
E’ Sergio Borelli a spiegare cosa è Input e a dare all’argomento una sferzata inaspettata.
“Input è un termometro. Misura la temperatura della televisione pubblica nel mondo. Sempre in bilico tra avere rilievo o essere inutile, tra esser degna dei finanziamenti pubblici o essere distrutta con una programmazione commerciale di bassa lega. Forse è arrivato il momento di chiederci perché la tv pubblica deve esistere e a che prezzo”.
Cosa ti ha insegnato il Borelli padre e giornalista?
“Lui mi ha appassionata al tema del viaggiare e così è stato anche per due nipoti, ma soprattutto mi ha educata al lavoro critico di osservazione della realtà”.
Quali sono le qualità di tuo padre che ti hanno spinta a farne il protagonista del tuo documentario?
“Mio padre ha un pensiero indipendente da schemi e parametri e una capacità di analisi autonoma. Basta ascoltare ciò che dice nel sito riguardo alle icone e ai quadri religiosi che ha accumulato. E’ un uomo sui generis in tutto, anche nelle analisi di eventi attuali spesso mi stupisce per le sue intuizioni. La sua capacità di knowledge mi fa pensare ai grandi vecchi”.
Appari anche tu nel film?
“Ci sono anche io nel film, perché interagisco con mio padre e lo stesso fa mia nipote: per me è importante dare anche il mio punto di vista, quello dell’autore. Deve esserci anche l’autore, per stabilire una relazione chiara con il pubblico. Io ho lavorato molto negli Stati Uniti e penso al documentario verità di fine anni Sessanta, quando si poteva filmare qualsiasi cosa e si è però capito che quello che contava era il regista, perché era lui che sceglieva cosa filmare e che relazione stabilire con il pubblico”.
Hai trovato un produttore?
“Quando sono andata da vari produttori, mi chiedevano sempre: “Perché tuo padre e non altri giornalisti famosi?”. La questione è che non penso si debbano raccontare solo le storie di chi è famoso. Io penso che anche la persona comune ha il patrimonio della vecchiaia e la sua storia qualunque fa risuonare principi universali che riguardano poi alla fine noi tutti. Perché confinare l’anziano nel suo mondo? In fondo dipende da come lo analizzi, da come lo guardi far emergere la sua storia”.
Certo, la comunicazione oggi viaggia così. Ma oltre questa linea di confine di appiattimento nei contenuti c’è molto, molto altro da scoprire sugli anziani. Lo vedremo nei prossimi anni. L’invecchiamento della popolazione, dicono gli studi dell’Oms, sta mettendo il mondo di fronte ad una situazione senza precedenti; presto avremo a livello globale una popolazione fatta più di anziani che di bambini e gente in una età così avanzata, come mai era accaduto prima. Ci attende una grande sfida, abbiamo bisogno di studiare, riflettere, osservare. Creare nuovi approcci al non essere più giovani, ma anziani con una lunga, lunga vita di fronte.
Come si finanzia un progetto di questo tipo?
“Abbiamo completato la produzione e ora stiamo lavorando al montaggio. Speriamo di finire a dicembre. Abbiamo creato un Fondo per poter ricevere delle donazioni attraverso un fiscal sponsor che si chiama Der, Documentary Educational Resources. Le donazioni sono detraibili dalle tasse, basta accedere al sito di The House he built e scoprire come si fa. C’è una mailing list che tiene aggiornati sul procedere del montaggio. Stiamo studiando una campagna serrata con varie formule per ringraziare i futuri donatori, dalla citazione nei titoli di coda, ad un progetto in memoria di vostro padre o madre con il nome e tante altre cose”.
Il patriarca ha da poco compiuto 93 anni. Gli si possono fare gli auguri su Facebook.