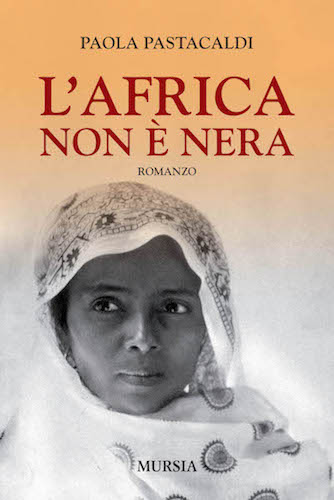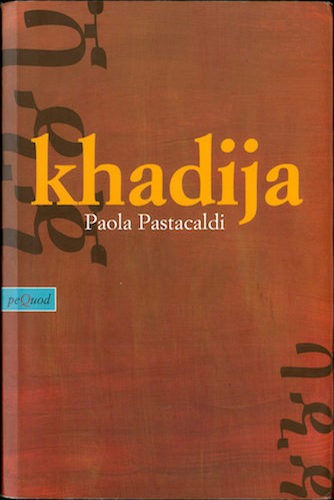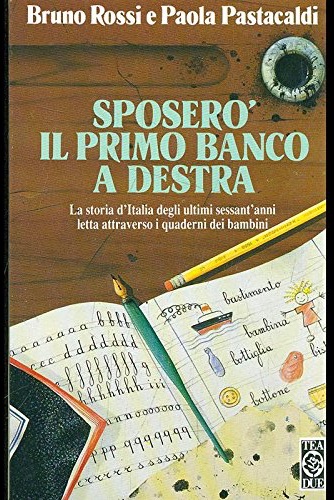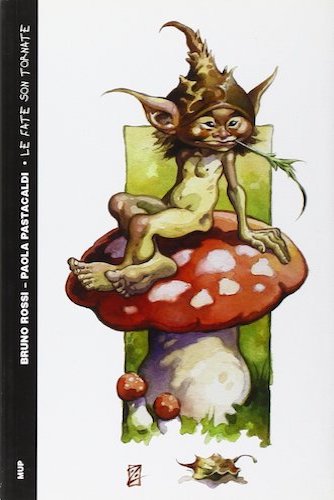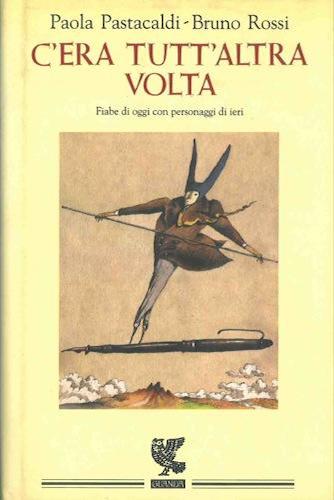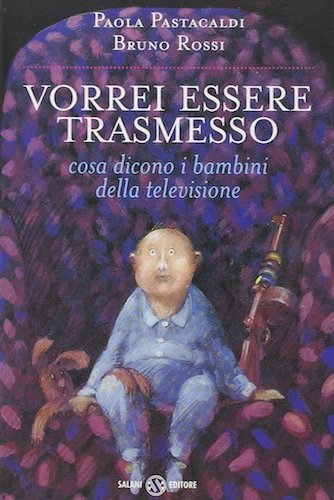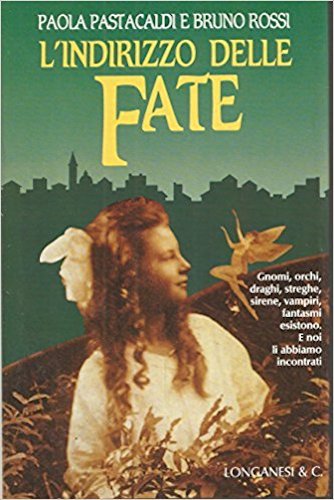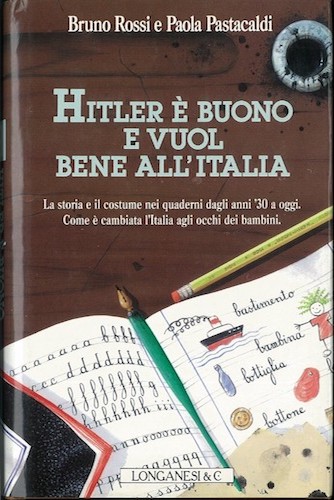“L’Africa non č nera”
di Paola Pastacaldi (editore Mursia, aprile 2015)
“L’Africa non è nera”. Un titolo inusuale per un romanzo che si stampa oggi. Perché un titolo così provocatorio?
“E’ il titolo di un articolo scritto per il Corriere della Sera da Curzio Malaparte, che tra gennaio e aprile del 1939 attraversò l’Etiopia per raccontare l’Impero bianco dell’Italia, e visitò anche l’Eritrea. Malaparte avrebbe voluto raccogliere e pubblicare le sue corrispondenze sull’Africa ma il libro non vide mai la luce. In quell’articolo descrisse le partenze dei coloni diretti in Abissinia. Povera gente, senza lavoro, molti contadini, ma anche artigiani e piccoli impresari che non sapevano nemmeno dove fosse nella cartina geografica questa Eritrea ma, in cuor loro, immaginavano una seconda patria. Il titolo è molto legato all’epoca e, ovviamente, provocatorio”.
Le colonie appartengono a un pezzo di storia dimenticata, perché legata alle miserie del fascismo?
“Ormai quasi tutti sanno che gli italiani in colonia, durante la guerra d’Etiopia, hanno usato il gas nervino e hanno ucciso migliaia di indigeni innocenti, non solo i soldati ma anche parte della popolazione. Indro Montanelli, che aveva fatto la Guerra d’Etiopia, aveva sempre negato l’uso del gas ma ormai è storia. Rodolfo Graziani, viceré d’Etiopia, nel 1937 fu responsabile di uno dei peggiori eccidi della storia coloniale. Fece uccidere per rappresaglia, dopo un attentato subito ad Addis Abeba, migliaia di giovani etiopi, futura classe dirigente del Paese, più una buona parte del clero, i monaci di Debra Libanos, ma anche gli indovini e i cantastorie, eredi di una tradizione orale e culturale tra le più nobili dell’Africa. Per quanto mi riguarda, mi sono concentrata sulla vita di Asmara e non sulla guerra d’Etiopia, sul lavoro degli italiani e le loro relazioni con le donne indigene. Ho voluto guardare alla vita vissuta con la lente di ingrandimento e uno sguardo letterario”.
Chi è il protagonista?
“Un italiano, un veneto di Treviso, partito in cerca di fortuna verso Asmara nel 1935, vissuto lì sino alla fine della colonia nel 1941, anche arricchendosi, e poi trattenuto dagli inglesi sino alla fine del protettorato nel 1951, lontano dalla famiglia e dalla Patria. Un italiano povero e figlio di contadini che parte con l’idea di costruire strade. Poi decide di fare un altro lavoro, capisce che serve acqua pulita ai suoi connazionali che sbarcavano ad Asmara a centinaia. E organizza la distribuzione casa per casa dell’acqua, prima con cavalli, poi con i camion Fiat fatti venire dall’Italia. Parlo di un periodo breve di quindici, sedici anni, ma così ricco di avvenimenti, di rivolgimenti avventurosi, a tratti rocamboleschi. Molto, molto interessanti per uno scrittore.
Nel 1935 ad Asmara in poco tempo sono arrivati migliaia di italiani e la città dovette svilupparsi anche architettonicamente in tutta fretta, diventando un prototipo eccellente di una piccola città di provincia italiana, una somma di tante provincie. Gli architetti dell’epoca costruirono di tutto, in molti stili diversi, neoclassico, romano, lombardo, liberty, razionalista, decò. Fecero bar, ristoranti, viali, ospedali, teatri, cinema, chiese di ogni credo, ortodosse, cattoliche e persino la moschea. La fantasia di quel periodo è riassunta nella stazione di servizio “Fiat Tagliero” in stile futurista dell’architetto Giuseppe Pettazzi, costruita nel 1938 con due grandi e lunghe ali distese e sospese nel vento, tanto da sembrare un aereo in decollo. Tutti pensavano, all’epoca, che sarebbe crollata e, invece, è ancora lì. Magnifica. Vogliamo parlare dell’impervia linea ferroviaria costruita sulle montagne dell’altopiano tra il 1887 e il 1932, 118 kilometri di binari? Sospesa a 2300 metri di altezza, una littorina che da Massaua sul mare si inerpica sull’altopiano. E’ stata riattivata qualche anno fa per un breve tratto”.
Esiste una vera memoria collettiva del periodo coloniale?
“Si dice che un italiano su tre abbia una memoria coloniale in casa. Nascosta in qualche cassetto e quasi completamente dimenticata. Gli italiani non hanno affrontato la materia e fatto una corretta rielaborazione di quel periodo.
Lei ha una sua memoria collettiva…
Sì. Ho due storie familiari. Due nonni che sono arrivati in Etiopia. Mia madre, la figlia di quel nonno partito nel 1935, mi raccontava tante storie. Nella memoria che è giunta fino a me, è chiaro che in quel periodo la vita nelle colonie era intensa e unica. Dovevano creare tutto da zero: ciò che serviva per sopravvivere, ma anche per vivere al meglio. Ad Asmara, al Circolo degli Italiani, si facevano feste e balli, ma c’erano anche il tennis, i campi da golf. Tutto dipendeva dalla loro capacità di inventare. La fame li aveva spinti, ma la fantasia aveva dato le ali ai loro bisogni. Sfogliando il “Chi è? dell’Eritrea” del 1952 di Giovanni Puglisi o “La Guida dell’Africa Orientale Italiana” del Touring del 1938, si scopre quanto italico ingegno si sia sviluppato prima e dopo sotto l’ombra dell’Union Jack, la bandiera inglese, come ha scritto in un titolo indovinato lo studioso Nicholas Lucchetti. Mancavano i rifornimenti dall’Europa, perché il canale di Suez era chiuso. Crearono tutto con inventiva, dalla birra, facendo esperimenti nel bagno di casa, ai motori, ai medicinali, al cioccolato con le noci di cocco, al vino con i fichi d’india, alle scarpe. Dopo il 1941 fu un autentico tripudio di prodotti. Alla biblioteca diplomatica della Farnesina si può consultare un ricco Catalogo della mostra dei prodotti d’Oltremare e capire quanta capacità produttiva e artigianale avevano gli italiani”.
Cosa altro le raccontava sua madre ?
“La ex colonia, a fine Anni Quaranta, era per lei un luogo estremamente divertente, nonostante le difficoltà politiche e gli attacchi dei banditi shifta. Si viveva come in una città grande, forse internazionale, non trascurando la bella vita. Per questo i ricordi di mia madre sono anche giustificati. Gli inglesi avevano portato le loro abitudini. All’indomani della loro occupazione di Asmara, 1 aprile 1941, fecero una grande festa all’Hotel Ciaao, l’ex Compagnia Alberghi Italiani Africa Orientale. E chi suonava? Un’orchestra italiana. Nel mio romanzo la musica fa da colonna sonora a tutto quel periodo, ininterrottamente. Si comincia nel 1935 con “Faccetta Nera, bell’Abissina” e si passa a “Ma Pippo Pippo non lo sa”, “Un’ora sola ti vorrei”, a “L’Oasi di Giarabub,” “Serenata a Sellassiè”, “Potessi avere mille lire al mese”, e, infine, con gli inglesi arriva anche la musica dei neri americani, il boogie-woogie. Gli italiani sanno adattarsi facilmente e velocemente. Certo tra il 1941 e il 1943 è stata durissima; ci sono stati migliaia di prigionieri e le navi bianche, quelle della Crocerossa, a salvare chi voleva tornare in patria, circumnavigando l’Africa. Molti nel mio paese ricordavano, fino ad una ventina di anni fa, la nave Nova Scozia che fu bombardata per errore e morirono in tanti.
In che modo emerge nel romanzo il rapporto con le donne indigene?
“Ci sono incontri amorosi, storie di sesso, ma anche sentimentali. Gli italiani partivano spesso soli, le mogli e le figlie rimanevano a casa. Il rapporto con le donne indigene è stato fondamentale. E’ il tema centrale degli ultimi studi sulle ex colonie. Le relazioni con le donne fiorivano spontanee, il mito della Venere Ottentotta furoreggiava tra i soldati. Poi sono arrivate le durissime leggi razziali: era proibito avere una donna nera come moglie, pena tre anni di galera, proibito avere, adottare o riconoscere figli meticci. E questi italiani, spaventati, le abbandonarono con i loro figli. Un capitolo terribile e ignorato del nostro colonialismo. Tutto da raccontare. I figli di queste unioni, i meticci, oltretutto erano anche rifiutati, odiati, dagli eritrei stessi, come ha raccontato Erminia dell’Oro nel romanzo “L’Abbandono”. C’è da dire che Giulia Barrera, archivista di Stato di Roma, ha scritto un interessante articolo sulla patrilinearità, razza e identità in colonia in cui si documenta come non tutti gli italiani rispettassero le leggi. Dunque, è utile guardare con la lente di ingrandimento dentro questi pochi anni. Nel mio romanzo racconto il desiderio degli italiani coloni di avere una donna, la novità di avere un’indigena come moglie, la facilità di queste relazioni. La scoperta del sesso. E c’è anche la storia di un giovane meticcio, molto bello e colto, che non è stato abbandonato, ma è stato educato all’italiana, perché figlio di un italiano benestante che ha una storia d’amore con un’italiana. Il suo percorso e la sua crescita rappresentano simbolicamente l’Africa coloniale, prima sottomessa, poi convinta di essere italiana e, infine, capace di rifiutare l’Italia e rivendicare l’indipendenza”.
Quali sono state le sue fonti?
“Gli storici ufficiali, tutti, e quelli più giovani che stanno rianalizzando il periodo con saggi critici. Ma anche i diari privati dell’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, le foto d’epoca dell’Isiao, l’Istituto di Studi Italo africani, ormai chiuso, la Biblioteca Archivio Africana di Gian Carlo Stella a Fusignano, e poi quelli di alcuni professori. Ma anche qualche storia privata scovata da sola, e raccontata da figli, da nipoti di camionisti che ancora ricordano tutto, che conservano le foto delle ex colonie. Memorie rare e bellissime, nel senso del costume. Ho anche cercato e esaminato cartoline e foto, trovando dettagli interessantissimi. Ho trovato le cartoline di Maria Josè che faceva la crocerossina tra i soldati, ma anche quelle delle prostitute chiamate mambrucche che c’erano a Suez, e che posavano orgogliose a seno fiorente e nudo e un anello al naso. La didascalia diceva: ricca donna araba. Credo per pudore. Mi immagino l’agitazione di un contadino che arrivava sul Mar Rosso e gli dicevano che nei bordelli poteva andare con le mambrucche egiziane. Molti giovani dilapidavano i loro pochi soldi ricevuti dai genitori e ripartivano da Suez per Massaua poveri in canna.
Lei ha vissuto in Africa?
“Sono stata portata da mia madre ad Asmara poco dopo essere nata e poi, quando avevo circa sei anni, ho vissuto per un anno intero, andando a scuola lì. Poi sono tornata in Italia. La ricerca delle radici mi ha spinta varie volte in Etiopia ed in Eritrea. Uno dei viaggi più commoventi è stato quando ho deciso di cercare la tomba di mio nonno, Giuseppe Pastacaldi che sapevo sepolto nel cimitero cattolico di Harar, città musulmana ai confini con la Somalia, non facile da raggiungere. Ci sono i disegni di alcuni esploratori tra i quali Giuseppe Maria Giulietti, ucciso in Dancalia nel 1881, che la ritraggono così isolata sulla cima di una altura, con le euforbie intorno. All’epoca era nota per il caffè. Una città musulmana in un impero che è sempre stato cristiano. Lo stesso Richard Burton, l’esploratore che per primo a metà Ottocento riuscì ad entrare dentro le sue mura, lo fece travestito da arabo. Harar aveva la fama di considerare una disgrazia l’ingresso degli stranieri dentro le sue antiche mura. Mio nonno Giuseppe Pastacaldi vi approdò a fine Ottocento, percorrendo la carovaniera degli schiavi. Oggi è città Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Per arrivarci con un aereo si raggiunge Dire Daua e poi si procede in auto per un paio di ore.”.
E ha trovato la tomba di suo nonno?
“Sono entrata nel piccolo cimitero di Harar, accompagnata da una guida locale. Le mura erano intatte, ma dentro era stato tutto distrutto, le tombe dell’Ottocento erano state scoperchiate e le lapidi spezzate. A terra tante ossa. Rabbrividisco al pensiero di quando ho capito che, tra tanta erba secca e molto alta, stavo calpestando ossa di morti. Intorno, tanti bambini sorridenti giocavano, il cimitero era diventato forse un luogo della loro fantasia, uno era addirittura arrampicato sulla cima di una palma altissima, altri avevano magre caprette al seguito. Mi vennero tutti intorno, curiosi come avviene spesso in Africa. Bimbi bellissimi dai volti sorridenti con piccoli mazzi di fiori tra le braccia, raccolti chissà dove. Insomma una visione quasi magica. Nella città non c’erano turisti, ero l’unica ospite di un piccolo albergo di stampo coloniale con un custode a difenderne l’ingresso, che sembrava una copia di Mussolini, con calzoni coloniali e baffetti. Diciamo che sono stata nel luogo dove sono i resti di mio nonno ma non posso dire di averli identificati. Questo mio nonno, Giuseppe Pastacaldi, ha lavorato per il Governo Italiano, più volte citato dal ministro Ferdinando Martini nel suo libro “Nell’Affrica italiana”. Si unì ad una donna musulmana di nome Khadija, di una famiglia oromo, poi convertita in Maria, probabilmente dal vescovo francese Marie-Elie Jarosseau, vissuto ad Harar per aiutare i cattolici, che avevano vita difficile. La storia di questa donna, inizialmente consegnata in omaggio a mio nonno, e del loro amore l’ho raccontata nel mio primo romanzo dedicato all’Etiopia, edito da peQuod, Ancona. Il titolo è Khadija”.
Romanzo che ha vinto un premio, vero?
“Sì. ll Premio letterario Città di Vigevano nel 2005”.